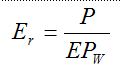No, Emanuela, non è stato a Matera. O meglio: sì, è stato anche a Matera, ma in effetti mi sembrava di averlo detto un pochino prima, ad esempio a Massa e Cozzile, un mese prima (il 27 aprile), e sicuramente anche prima. Che si sarebbe andati verso il cosiddetto bail-in, cioè verso il salvataggio delle banche a spese dei depositanti, come pare abbia poi definitivamente annunciato l'ultimo Ecofin, a me (e suppongo anche a molti altri) è stato immediatamente chiaro, fin dalla dichiarazione, che allora sembrò scandalosa, del simpatico pilota dell'aereo più pazzo del mondo, l'attuale capo dell'Eurogruppo, sì, lui, il simpatico voleur de grand chemin che aveva esordito a febbraio nazionalizzando una banca della virtuosa Olanda (la SNS), ed espropriandone gli obbligazionisti per lo più provenienti dai viziosi GIPSI (come ricorda, inascoltato, Claudio Borghi).
Proprio lui, il campione di questo bel gesto di razzismo finanziario (e come altro lo vuoi chiamare?) il 25 marzo aveva mandato a gambe all'aria i mercati dicendo che Cipro sarebbe diventato il modello (template) per la soluzione delle crisi bancarie nell'Eurozona.
Ma ad essere onesti, non è lì che ho capito. Ho capito subito dopo, quando le sue dichiarazioni sono state smentite.
A quel punto tutto è diventato chiaro: eravamo di fronte all'ennesima applicazione del metodo Juncker. Questo metodo, viceversa, ricordo quando l'ho descritto per la prima volta. L'ho fatto ad Arezzo e poi subito dopo a Radicondoli, a gennaio (cioè prima della nazionalizzazione della SNS e prima che Cipro diventasse un modello). In cosa consiste? Semplice! In una oculata gestione del flusso informativo secondo il noto principio della rana bollita. Sentiamo come lo descriveva nel 1999 sullo Spiegel il simpatico Jean-Claude Juncker, lussemburghese, predecessore di Dijsselbloem all'Eurogruppo:
"Prendiamo
una decisione, poi la mettiamo sul tavolo e aspettiamo un po’ per vedere che
succede. Se non provoca proteste né rivolte, perché la maggior parte della
gente non capisce niente di cosa è stato deciso, andiamo avanti passo dopo
passo fino al punto di non ritorno"
Ah, scusate se ve lo faccio notare: la gente siete voi...
Vorrei anche ricordare che non ero stato io a "riscoprire" il metodo Juncker. Era stata la contessa Elvira a portarlo alla nostra attenzione (con la collaborazione di Chicco DM), traendola da un noto scritto di Enszenberger. Tanto per precisare che i "tedeschi" non sono tutti uguali, e che tanto devo io a voi quanto voi a me.
Ma torniamo al metodo Juncker.
Con la storia del bail-in è stata attuata la stessa strategia, in due mosse.
Prima hanno mandato avanti quello zuzzurellone di Dijsselbloem, smentendo quasi in contemporanea (visto il patatrac sui mercati). Poi hanno mandato avanti il pezzo da novanta, l'amico Schaeuble, che era partito dicendo che Cipro era un caso particolare (il 30 marzo), ma poi, guarda un po', il 20 aprile aveva già cambiato idea, senza che l'opinione pubblica, già sufficientemente bollita, se ne inquietasse particolarmente. A quel punto sapevano che la strada era aperta, e sono andati avanti.
Notate un altro raffinato dettaglio, che a molti commentatori mi pare sia sfuggito, e del quale mi scuso di non riuscire a ritrovarvi ora la fonte (ma sono certo di averlo sentito alla radio, e voi saprete trovarla per me, perché molti di voi saranno stati colpiti come me): Schaeuble ha detto, in buona sostanza, che questo accordo serve a evitare danni peggiori, cioè che i depositanti devono scegliere fra farsi togliere i soldi, o sopportare le conseguenze catastrofiche di una crisi bancaria.
Chiaro il punto, no? "Signori, siamo arrivati a un punto di non ritorno: ora non si può fare che come diciamo noi".
Esattamente la stessa logica di chi parla di euro irreversibile.
La logica Juncker.
Non entro in alcune ovvie considerazioni tecniche che sono ampiamente svolte nelle fonti citate, riferite ad esempio alla molto probabile inefficacia di questa misura, alla sua iniquità (perché in fin dei conti rischia di colpire soggetti tipicamente avversi al rischio come spesso sono gli acquirenti di obbligazioni bancarie), agli enormi problemi di moral hazard che crea (perché se questa è la musica, è chiaro che le banche sanno di poter fare sostanzialmente come gli pare), al fatto che i "beati" che si sentono al sicuro perché hanno 99.999 euro in banca non capiscono che questa misura rischia di colpire la tesoreria dell'impresa presso la quale lavorano, ecc.
Espertoni e complottisti "a prescindere" entreranno in discussione per confutare questo o quel punto, dimenticando un dato essenziale: a quanto capisco, per ora siamo ancora a una proposta piuttosto improvvisata (per quanto ufficiale), a un disegno, nel quale mancano importanti dettagli (ad esempio, quando entrerà effettivamente in vigore e chi sarà "il boia", cioè quale organismo e con quale processo deciderà chi paga quanto). Quindi in effetti c'è poco da discutere e molto da stare attenti (ci sarebbe stato anche molto da protestare, ma, appunto, evidentemente siamo bolliti...).
Come sempre c'est le ton qui fait la musique: si continua a parlare di debito pubblico per distogliere l'attenzione dagli immensi debiti privati e dal modo in cui li si vuole gestire, che è un modo improntato alla logica della conditionality, una logica che tante soddisfazioni ha dato ai paesi dell'America Latina, i quali infatti adesso la rifiutano. Noi ancora no, e non capisco perché, né so prevedere fino a quando.
Concludo con una piccola avvertenza sul significato dei QED. Attenzione, voi lo capite, ma ai nuovi bisogna specificarlo: non sto giocando al gioco dell'"io l'avevo detto". Non ci ho mai giocato perché mentre all'estero avrei sicuramente perso, in Italia non ci sarebbe stata partita (con poche eccezioni che conoscete), ma non ci ho giocato mai soprattutto perché è un gioco futile e diseducativo.
Il lavoro che stiamo facendo qui si basa su un paio di assi portanti.
Il primo è quello di dare una formazione solida su alcuni concetti macroeconomici di base, ancorandoli ad esempi concreti e partendo sempre dal rispetto del dato, e quindi della contabilità. Che questo sia un lavoro utile lo dimostra, a contrario, il fatto che tutti i movimenti più o meno fascisteggianti in ambito economico, dai rumorosi d'America ai marxisti dell'Illinois (passando per decrescisti, donaldiani, et id genus omne) generalmente articolano il loro discorso su un attacco frontale alla logica della contabilità nazionale (vi risparmio gli esempi che conoscete: da quelli che "il Pil è un'invenzione capitalista" a quelli che "il Pil misura solo i prodotti materiali brutti e inquinanti" a quelli che "le identità della contabilità nazionale sono banali" a quelli che "il vincolo esterno non esiste" a quelli che...). Quindi ribadire i semplici fatti contabili che governano le relazioni economiche, e utilizzarli come chiave per una corretta lettura della realtà, come abbiamo fatto qui e qui, è di per sé (purtroppo) un atto rivoluzionario. In Italia il 99% degli intervenienti nel dibattito non ha ancora chiaro che ogni debito di qualcuno è il credito di qualcun altro, tanto per dire. Voi, se siete qui da un quarto d'ora, siete già avanti a tutti questi cialtroni.
Il secondo è quello di smascherare i meccanismi più o meno consapevoli (nel caso di Juncker la consapevolezza è piena e dichiarata) che governano la rappresentazione dei fatti economici inquinando il processo democratico nel nostro paese. A questo mi dedico spesso sul Fatto Quotidiano (ad esempio qui, o qui), ma anche in questo blog, perché ritengo che in fondo questo sia il lavoro più importante: quello di darvi strumenti critici per decodificare le trappole nelle quali l'informazione più o meno consapevolmente di regime vuole più o meno dolosamente farvi cadere. Quanta consapevolezza e quanto dolo ci siano, lo ripeto per l'ennesima volta, mi interessa poco. Mi interessa molto che impariamo a riconoscere ed evitare le trappole, e a questo mi dedico, e a questo servono soprattutto i QED. Segnalare che la storia del bail-in è in effetti l'applicazione di una strategia comunicativa piuttosto ovvia e dichiaratamente rivendicata dai vertici europei mi sembra un lavoro utile in questo senso.
(Molto più utile, se non altro, del lavorio convulso e inverecondo dei tanti piccoli diffamatori che cercano di dimostrare ai loro putrescenti referenti politici, o alla loro infinitesimale constituency, di averlo più a sinistra. Su di loro, come su quelli che ce l'hanno lungo, la Storia ha già steso, e rimboccato per bene, una bella pietra tombale. Vi rinnovo quindi, in cambio dell'interesse che il lavoro che stiamo facendo qui eventualmente promuovesse in voi, la mia richiesta di rispettare le mie narici. Inutile perder tempo. Andiamo avanti col nostro lavoro, perché qui si lavora.
Grazie ancora a tutti voi per il vostro stimolo e il vostro contributo.)
L’economia esiste perché esiste lo scambio, ogni scambio presuppone l’esistenza di due parti, con interessi contrapposti: l’acquirente vuole spendere di meno, il venditore vuole guadagnare di più. Molte analisi dimenticano questo dato essenziale. Per contribuire a una lettura più equilibrata della realtà abbiamo aperto questo blog, ispirato al noto pensiero di Pippo: “è strano come una discesa vista dal basso somigli a una salita”. Una verità semplice, ma dalle applicazioni non banali...
domenica 30 giugno 2013
venerdì 28 giugno 2013
QED 21: "Germany is saving itself to death." Veramente!?
Forse è il caso di riprendere la simpatica consuetudine dei Quod Erat Demonstrandum, che magari suonano pedanti, ma qualche utilità indubbiamente la presentano.
Intanto, servono a far capire che le sorprendenti scoperte di certi mezzi di informazione in realtà hanno per oggetto la classica acqua calda. Lo si mette in evidenza non per vanità personale (sarebbe fuori luogo: ormai sul carro dell'"io l'avevo detto" son saltati tutti, perfino Boeri!), quanto per sottolineare che il metodo economico, nella sua apparente e illusoria (per gli ingegnIeri) semplicità, consente effettivamente di antivedere certi esiti. Chiamiamolo spirito di giustizia.
Poi, i QED forniscono ai nuovi arrivati un utile pretesto per andarsi a rileggere alcuni articoli fondamentali di questo blog, e a tutti noi di vedere se questi articoli stanno reggendo alla prova del tempo. Sapete, oggi il mondo è cambiato, la storia va più in fretta, c'è la Ciiiiiiiiiiiina... Oppure no: ci sono le bestialità profferite a orologeria per interessi di bottega, e ci sono le semplici constatazioni di buon senso, se non eterne, quanto meno piuttosto resilienti all'urto del tempo.
Vi ricordate quando mettevo in evidenza il fatto che la crescita tedesca nell'età dell'euro era stata deludente e che per promuovere una crescita basata sulla domanda estera la Germania aveva soffocato la domanda interna e in particolare gli investimenti, il cui contributo alla crescita, nell'età dell'euro, era sceso dal 17% al 6% della crescita totale? Vi avevo anche ricordato che economisti tedeschi non ottusangoli né ellissoidi, come Ulrich Fritsche, erano un po' preoccupati da questa evoluzione, che secondo loro rischiava di compromettere la crescita potenziale della Germania.
Bene.
Quasi un anno e mezzo dopo lo Spiegel ci dice che la politica di repressione degli investimenti interni rischia di compromettere la crescita futura, secondo il DIW (nientemeno).
Come dire, l'importante è partecipare...
Diciamolo in un altro modo. Noi sappiamo che CA = S - I, giusto? Bene. Forse qualcuno, magari quelli che "la crisi è colpa dei greci perché mi' nonna risparmiava", penserà che siccome la Germania è brava (per definizione), il suo CA>0 (il suo surplus di partite correnti) derivi da un grande S (cioè da un elevato risparmio), il quale acriticamente è visto come cosa buona a prescindere.
Invece no, le cose non stanno così. Non solo e non tanto per l'ovvio motivo contabile che un elevato risparmio in un paese necessariamente si associa a un insufficiente risparmio in un altro (e quindi, appunto, in linea di principio sarebbe bene che lo sviluppo dei flussi fosse equilibrato).
No: per un altro è ben più cogente motivo. Perché studiosi di uno dei più prestigiosi centri di ricerca tedeschi (non quei fanatici antieuro di una certa università di provincia...) ammettono che il CA>0 è dovuto anche e soprattutto a un basso I, cioè a bassi investimenti, e che questo sicuramente creerà problemi in futuro al paese. E ora che diranno quelli che "il problema è la produttività e la Germania è produttiva perché fa più investimenti"? Finché il loro ragionamento semplicistico, dilettantesco, ideologico, cialtronesco non era nei dati, potevano anche sopravvivere. Ma ora che il contrario è scritto sullo Spiegel, forse per loro si mette un po' peggio.
Ai nostri simpatici Quisling auguriamo miglior fortuna con la prossima balla.
Quanto ai politici tedeschi autori di questo fallimento macroeconomico, non dobbiamo preoccuparci per loro. Quando i loro elettori gli chiederanno il conto, la soluzione sarà a portata di mano. Quale? La solita: dire che la colpa del disagio causato dalla miopia delle loro politiche è in realtà nostra, della nostra pigrizia e della nostra corruzione.
A proposito, vado a farmi una pennica (se ci riesco). E voi?
Intanto, servono a far capire che le sorprendenti scoperte di certi mezzi di informazione in realtà hanno per oggetto la classica acqua calda. Lo si mette in evidenza non per vanità personale (sarebbe fuori luogo: ormai sul carro dell'"io l'avevo detto" son saltati tutti, perfino Boeri!), quanto per sottolineare che il metodo economico, nella sua apparente e illusoria (per gli ingegnIeri) semplicità, consente effettivamente di antivedere certi esiti. Chiamiamolo spirito di giustizia.
Poi, i QED forniscono ai nuovi arrivati un utile pretesto per andarsi a rileggere alcuni articoli fondamentali di questo blog, e a tutti noi di vedere se questi articoli stanno reggendo alla prova del tempo. Sapete, oggi il mondo è cambiato, la storia va più in fretta, c'è la Ciiiiiiiiiiiina... Oppure no: ci sono le bestialità profferite a orologeria per interessi di bottega, e ci sono le semplici constatazioni di buon senso, se non eterne, quanto meno piuttosto resilienti all'urto del tempo.
Vi ricordate quando mettevo in evidenza il fatto che la crescita tedesca nell'età dell'euro era stata deludente e che per promuovere una crescita basata sulla domanda estera la Germania aveva soffocato la domanda interna e in particolare gli investimenti, il cui contributo alla crescita, nell'età dell'euro, era sceso dal 17% al 6% della crescita totale? Vi avevo anche ricordato che economisti tedeschi non ottusangoli né ellissoidi, come Ulrich Fritsche, erano un po' preoccupati da questa evoluzione, che secondo loro rischiava di compromettere la crescita potenziale della Germania.
Bene.
Quasi un anno e mezzo dopo lo Spiegel ci dice che la politica di repressione degli investimenti interni rischia di compromettere la crescita futura, secondo il DIW (nientemeno).
Come dire, l'importante è partecipare...
Diciamolo in un altro modo. Noi sappiamo che CA = S - I, giusto? Bene. Forse qualcuno, magari quelli che "la crisi è colpa dei greci perché mi' nonna risparmiava", penserà che siccome la Germania è brava (per definizione), il suo CA>0 (il suo surplus di partite correnti) derivi da un grande S (cioè da un elevato risparmio), il quale acriticamente è visto come cosa buona a prescindere.
Invece no, le cose non stanno così. Non solo e non tanto per l'ovvio motivo contabile che un elevato risparmio in un paese necessariamente si associa a un insufficiente risparmio in un altro (e quindi, appunto, in linea di principio sarebbe bene che lo sviluppo dei flussi fosse equilibrato).
No: per un altro è ben più cogente motivo. Perché studiosi di uno dei più prestigiosi centri di ricerca tedeschi (non quei fanatici antieuro di una certa università di provincia...) ammettono che il CA>0 è dovuto anche e soprattutto a un basso I, cioè a bassi investimenti, e che questo sicuramente creerà problemi in futuro al paese. E ora che diranno quelli che "il problema è la produttività e la Germania è produttiva perché fa più investimenti"? Finché il loro ragionamento semplicistico, dilettantesco, ideologico, cialtronesco non era nei dati, potevano anche sopravvivere. Ma ora che il contrario è scritto sullo Spiegel, forse per loro si mette un po' peggio.
Ai nostri simpatici Quisling auguriamo miglior fortuna con la prossima balla.
Quanto ai politici tedeschi autori di questo fallimento macroeconomico, non dobbiamo preoccuparci per loro. Quando i loro elettori gli chiederanno il conto, la soluzione sarà a portata di mano. Quale? La solita: dire che la colpa del disagio causato dalla miopia delle loro politiche è in realtà nostra, della nostra pigrizia e della nostra corruzione.
A proposito, vado a farmi una pennica (se ci riesco). E voi?
giovedì 27 giugno 2013
Scene dalla vita di provincia: prefazione
(questa è la
prefazione a un numero speciale di Comparative Economic Studies che ho curato e
nel quale sono raccolti gli articoli più significativi del seminario di
Pescara. Sì, sapete, quella piccola università di provincia dove degli
strampalati docenti ai margini della comunità scientifica sbraitano nella loro
allucinata demenza delle tesi assurde, che ovviamente mai troverebbero
accoglienza in una rivista scientifica internazionale. O no? La prosa è quello
che è, perché l’ho scritto in inglese e poi l’ho tradotto in italiano per i più
beati fra voi. E la cosa divertente è che sicuramente fra quelli che hanno
bisogno della traduzione ce ne sarà un 99.9% che prima di capitare su questo
blog avrà pensato che la soluzione fossero gli “Stati Uniti d’Europa”. Su,
piddinucci, dai, confessate: liberatevi da questo peso, e dopo vi sentirete
meglio...)
Questo numero speciale raccoglie le prolusioni di Roberto Frenkel (qui in versione
preliminare) e Ugo Panizza
(qui la
presentazione, qui
il video della prolusione) al seminario “The euro: manage it
or leave it!” tenutosi a Pescara il 22 e 23 giugno del 2012, insieme con un
articolo di Andrea Boltho e Wendy
Carlin (non presentato al seminario). Il seminario è stato organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università
Gabriele d’Annunzio in collaborazione con l’International Network for Economic
Research (INFER) e affrontava il tema
dei costi economici, sociali e politici delle strategie di uscita dalla crisi
dell’Eurozona.
Nel momento in cui scriviamo questo articolo (giugno 2013)
il tema è sempre attuale. Nella maggior parte dei paesi europei la fine della
recessione sembra oggi molto più distante di quanto non lo sembrasse un anno
fa. L’edizione dell’aprile 2012 del World
Economic Outlook (IMF, 2012)
prevedeva per il 2013 un tasso di crescita reale pari all1.0% in Francia, 1.4%
in Germania, e -0.3% in Italia. Un anno più tardi, l’edizione dell’aprile
2013 ha rivisto le stime di crescita al ribasso di circa un punto
percentuale pressoché ovunque, a -0.1%, 0.6% e -1.4%, rispettivamente. Infine,
all’inizio di giugno le previsioni di crescita della Germania sono state
dimezzate dal Fmi, passando dallo 0.6% allo 0.3%, il che suggerisce che anche l’economia
più forte e più resistente dell’Eurozona potrebbe essere travolta dalla
recessione che colpisce i suoi più importante mercati di sbocco.
Gli osservatori sono pressoché unanimi nel riconoscere che
le politiche di austerità praticate dai paesi periferici dell’Eurozona hanno
contribuito a questo disastro (come era peraltro stato anticipato
dal premio Nobel Stiglitz nel 2010). Le fondamenta empiriche dell’ipotesi di
“consolidamento fiscale espansionistico” sono state recentemente messe in
dubbio da numerosi studi, alcuni dei quali scritti dagli stessi autori che
negli anni ’90 avevano contribuito a fondare il “mito dell’austerity”; si
confronti, ad esempio, Alesina
e Perotti (1996) con Perotti (2011). Il
più importante articolo scientifico a sostegno delle politiche di austerità è
probabilmente stato quello di Reinhart e Rogoff (2010),
il cui successo presso gli uomini politici è stato certamente dovuto alla
semplicità del messaggio: “la mediana del tasso di crescita nei paesi dove il
debito pubblico supera il 90% del Pil è più bassa di un punto percentuale
rispetto agli altri”. Il nesso causale implicito in questa asserzione è stato
criticato da Ugo Panizza
e Andrea Presbitero (2012). Ciononostante, l’articolo di Reinhart e Rogoff
è stato citato ripetutamente dai media dell’Eurozona per sostenere l’ipotesi
che la scarsa crescita nei paesi del Sud dovesse essere curata con il consolidamento
fiscale. Di conseguenze, l’opinione pubblica è stata profondamente colpita
quando Herndon
et al. (2013) hanno mostrato che i risultati di Reinhart e Rogoff erano
affetti da errori di calcolo e dall’esclusione selettiva di dati. Ciò è
accaduto poco prima che IMF
(2013b) ammettesse “notevoli errori” nella gestione della crisi greca,
sottolineando che “la fiducia non è stata ristabilita”, che la recessione è
stata molto più profonda di quanto ci si attendesse, che i guadagni di
produttività sono stati illusori, ecc.
Sorge allora spontanea una domanda: perché mai durante la
crisi si adottano con tanta coerenza le politiche sbagliate, nonostante la
letteratura scientifica abbia così spesso messo in guardia contro i loro
effetti? I tre articoli presentati in questo numero offrono delle intuizioni
interessanti sulle possibili ragioni di questo enorme fallimento nella gestione
macroeconomica della crisi.
Il primo articolo, scritto da Andrew Boltho e Wendy Carlin,
fa un’osservazione interessante: l’Unione Economica e Monetaria è minacciata
dal persistere di divergenze strutturali delle politiche fiscali, della
competitività, e della qualità dell’azione di governo, piuttosto che dal
verificarsi di shock “asimmetrici”. Questa osservazione promuove diverse
riflessioni.
In primo luogo, le verifiche del fatto che l’Unione
Economica e Monetaria fosse o meno un’area valutaria ottimale (AVO) si sono
concentrate finora sul grado di asimmetria fra paesi membri: un aspetto che
poteva essere analizzato formalmente nell’elegante quadro di riferimento del
noto modello di Blanchard e Quah
(1989), il che ha verosimilmente contribuito al successo accademico di
questo approccio. L’analisi di Boltho e Carlin suggerisce che forse abbiamo
sopravvalutato il reale contributo di questo tipo di ricerche. In effetti,
anche senza considerare che i loro risultati sono stati piuttosto inconcludenti,
andando dall’euroscetticismo di Bayoumi e Eichengreen (1992)
all’eurottimismo di Kouparitsas
(1999), questi studi crollano di fronte all’evidenza incontestabile del
fatto che l’Eurozona è stata messa in ginocchio da un gigantesco shock “simmetrico”,
ovvero dalla crisi finanziaria statunitense, che li ha portati tutti in
recessione al tempo stesso.
In secondo luogo, i dati proposti dall’articolo mettono in
dubbio la rilevanza della cosiddetta teoria dell’“AVO endogena”. Questa teoria
afferma che entrando in un’unione monetaria, un gruppo di paesi elimina le
asimmetrie strutturali esistenti presenti al suo interno, attraverso una
quantità di meccanismi che vanno dall’aumentata mobilità dei fattori, alla
sincronizzazione dei cicli economici favorita dallo sviluppo del commercio,
alla convergenza dei tassi di inflazione tramite effetti di credibilità, ecc.
Un dibattito vecchio quanto la teoria delle AVO, tant’è vero che lo stesso Robert Mundell (1961),
nell’articolo che ha dato avvio alla ricerca sulle AVO, cita la controversia
fra James Meade (1957) e Tibor Scitovsky (1958), nella quale quest’ultimo
sosteneva il punto di vista “endogeno”. Una nota tesi sostiene che “legando le
proprie mani” alle politiche dei membri virtuosi dell’UE, i governi del Sud
avrebbero guadagnato credibilità internazionale e interna, facilitando la
convergenza dei propri tassi di inflazione a quelli dei paesi virtuosi (Giavazzi e Pagano, 1988).
La divergenza fra gli indicatori di competitività e di governance dei paesi del Nord e del Sud, documentata da Boltho e
Carlin, confuta questa ipotesi. In altri termini, pur riconoscendo il bisogno
di riforme essenziali nei paesi del Sud, ci si deve chiedere se la camicia di
forza dell’unione monetaria le abbia significativamente accelerate, o se
piuttosto le abbia impedite, come suggerisce Granville (2013) con
riferimento all’esperienza francese.
In terzo luogo, l’articolo di Boltho e Carlin ha importanti
implicazioni politiche. Si invoca spesso come soluzione ai problemi dell’Eurozona
un “grande balzo in avanti” verso una completa unione fiscale, portando, più o
meno a proposito, l’esempio degli Stati Uniti. Se il problema fosse il
verificarsi in di shock asimmetrici casuali, un’unione fiscale potrebbe in
effetti funzionare come meccanismo assicurativo fra i paesi membri, consentendo
a ogni paese di mantenere una posizione netta nulla in valore attuale medio (Ndc: oggi a me, domani a te, e in media
i trasferimenti da un paese all’altro nel lungo periodo di compenserebbero). Ma
siccome l’Eurozona è caratterizzata da divergenze strutturali persistenti, ne
deriva l’ovvia conseguenza che i trasferimenti fiscali andrebbero per un
periodo molto lungo in un’unica direzione: dal Nord al Sud. Come sottolineano
Boltho e Carlin, il “macrocosmo” dell’Eurozona si troverebbe così a replicare
le esperienze deludenti dei “microcosmi” di molti paesi membri, nei quali le
politiche di trasferimento dal Nord al Sud (in Italia e Spagna) o dall’Ovest
all’Est (in Germania) non hanno affatto compensato le divergenze strutturali e
si sono dimostrate sostenibili politicamente solo a causa di un senso di
identità nazionale più o meno profondo, la cui costruzione ha comunque
richiesto secoli. La fattibilità di una “unione di trasferimento” a livello
dell’Eurozona è quindi molto discutibile, sia perché costerebbe troppo ai
contribuenti del Nord (Jacques
Sapir, 2013, ha calcolato che, per compensare il divario di infrastrutture,
istruzione e spesa in ricerca e sviluppo, la Germania dovrebbe trasferire ai
paesi del Sud un ammontare pari a circa il 9% del proprio Pil), sia perché la
costruzione di un’identità europea è impedita dalla crisi dell’euro, che porta
con sé l’ovvia conseguenza di un aumento della diffidenza fra cittadini del
Nord e del Sud, e anche fra i cittadini dei diversi stati del Sud (un esito
previsto da economisti tanto diversi per formazione e orientamento quanto Nicholas
Kaldor, 1971, e Martin
Feldstein, 1997).
Nel secondo articolo, Roberto Frenkel confronta la crisi
dell’Eurozona con le crisi verificatesi negli ultimi trent’anno nei mercati
emergenti, analizzandole nel contesto del modello di ciclo minskyano. Questo
confronto fornisce molte intuizioni importanti.
In primo luogo, come l’adozione di un cambio “credibile” nei
paesi emergenti, così l’adozione dell’euro, con la “credibilità” ad esso
associata, è stato il fattore scatenante della fase espansiva del ciclo
finanziario nei paesi del Sud, incoraggiando la crescita dell’indebitamento
privato nei riguardi degli altri paesi dell’Eurozona. In altre parole, l’analisi
di Frenkel sottolinea che l’euro, invece di ridurre le divergenze strutturali
documentate da Boltho e Carlin, come sarebbe dovuto accadere secondo i teorici
dell’AVO endogena, le ha enfatizzate. Una spiegazione che col senno di poi
sembra in effetti molto plausibile. In fondo, lo scopo della moneta unica era
quello di facilitare i movimenti di capitale (l’impatto della moneta unica sul
commercio internazionale era previsto fosse piuttosto contenuto – Eichengreen,
1993 – come i fatti hanno confermato – Berger and
Nitsch, 2008). Come sottolinearono a suo tempo Blanchard
e Giavazzi (2002), questo risultato avrebbe anche potuto avere effetti
positivi nell’Eurozona, dove notevoli disparità fra i paesi membri lasciavano
ampio spazio per un processo di catch-up.
Ma l’assenza di regolamentazione finanziaria ha trasformato questi benefici
potenziali in un disastro, secondo un copione sperimentato in precedenza da numerosi
paesi emergenti.
In secondo luogo, Frenkel affronta il tema del perché le giuste
politiche macroeconomiche siano così tragicamente scarse durante le crisi
finanziarie. Secondo Frenkel questo infelicissimo risultato deriva dal
comportamento razionale di governi che operano in una situazione molto simile
al classico “concorso di bellezza keynesiano”. Dato che la sostenibilità dei
loro debiti dipende da una “aspettativa autorealizzantesi circa l’opinione media
diffusa nel mercato” (nelle parole di Frenkel), i governi, piuttosto che
praticare le politiche che ritengono corrette, adottano quelle che essi
ritengono che l’opinione dominante sul mercato troverà corrette. In questo
contesto le misure di austerità sono razionali, perché forniscono un segnale
rassicurante per l’opinione dominante sui mercati. Tuttavia, queste politiche
sono destinate a un inevitabile fallimento, perché la politica idealmente
corretta sarebbe, come notano Boltho e Carlin, quella di sostenere la domanda
con ulteriore debito pubblico per favorire il rientro del settore privato dai
propri debiti.
Il terzo articolo, di Ugo Panizza, fornisce ulteriori
intuizioni sulla dinamica politica delle crisi finanziarie rispondendo a due
diverse domande: perché le politiche messe in pratica sono così inadeguate? E
perché la risoluzione di una crisi, eventualmente sotto forma di un default
sovrano, viene sempre rimandato, anche quando questo ne aumenta tragicamente i
costi sociali, come è successo in Grecia?
La risposta alla prima domanda risiede nelle asimmetrie
informative fra i governi e i loro elettori. Una pessima economia può diventare
(o sembrare) una buona politica perché, come dice Paul
Krugman (2012), “è normale pensare all’economia come a una favoletta morale”.
La favoletta è quindi facile da spiegare al pubblico, ma mette sotto pressione
i governi che la raccontano, costringendoli ad adottare o imporre politiche
procicliche che esacerbano la crisi. Un altro punto interessante sollevato da Panizza
è che, in molto casi, le politiche fiscali sono concepite in modo inappropriato
perché si soffermano sulla causa sbagliata della crisi. In effetti, l’evidenza
empirica dimostra che la dinamica del debito pubblico è influenzata in modo
significativo da una componente di riconciliazione stock/flusso le cui origini
rimangono ampiamente ignote e la cui gestione quindi ricade per lo più al di
fuori dell’ambito della politica di bilancio.
La risposta alla seconda domanda (perché i politici rinviano
i default?) è duplice: da una parte, politici mossi da interessi personali possono
temere il costo politico della propria decisione; dall’altra, politici
disinteressati possono voler attendere fino a che non sia emersa nei mercati la
consapevolezza unanime del fatto che il default è inevitabile, anziché essere
strategico (cioè frutto di un comportamento opportunistico), perché ciò ne
ridurrebbe il costo economico (in termini di perdita di fiducia da parte dei
mercati).
Gli stessi argomenti potrebbero applicarsi all’uscita di un
paese dall’Eurozona. Gli articoli presentati hanno opinioni diverse su questo
punto. Frenkel considera l’euro irreversibile: un punto di vista condiviso da
quelli che credono che l’immenso “capitale politico” investito nel progetto
(per citare Mario
Draghi, 2013), impedirà a politici mossi da interessi personali di
smantellare l’Eurozona. La soluzione della crisi, secondo Frenkel, comporterà
prima o poi una ristrutturazione dei debiti e probabilmente l’evoluzione della
Bce che dovrà diventare un credibile prestatore di ultima istanza per i governi
dell’Eurozona. Boltho e Carlin hanno una visione più pessimistica: dato che le
divergenze in termini di competitività sono molto difficili e costose da
ridurre attraverso la “svalutazione interna” (leggi: taglio dei salari, NdC), i costi percepiti della permanenza
finiranno per superare quelli dell’uscita. La storia insegna che molti altri
progetti politici ambiziosi sono dovuti venire a patti con l’inesorabile logica del
ragionamento economico. L’URSS è un buon esempio, dato che il capitale politico
investito nella sua creazione e nel suo mantenimento è stato senz’altro più
ampio di quello investito nell’Eurozona, ma il rendimento di questo capitale in
tutta evidenza non è stato sufficiente a impedire il collasso del sistema (Kawalec e Pytlarczik, 2013,
forniscono altri esempi). Questo semplice fatto suggerisce che nel prossimo
futuro lo studio di strategie di uscita ottimali potrà sembrare meno astratto e
teorico di quanto non sembri adesso.
Bibliografia
Alesina, A, Perotti, R. 1996: Fiscal adjustments in OECD countries:
composition and macroeconomic effects. NBER Working Paper No. 5730, August.
Bayoumi, T and Eichengreen, B. 1992:
Shocking aspects of European Monetary
Unification. NBER Working Paper No. 3949, January.
Berger, H and Nitsch, V. 2008:
Zooming out: The trade effect of the euro in historical perspective. Journal of International Money and Finance,
27, 1244-1260.
Blanchard, O and Giavazzi, F. 2002:
Current account deficits in the Euro Area: the end of the Feldstein-Horioka puzzle?
Brookings Papers on Economic Activity,
33, 147-210.
Blanchard, O and Quah, F. 1989: The
dynamic effects of aggregate demand and aggregate supply disturbances. American Economic Review, 79, 665-673.
Draghi, M. 2013: Press conference
following the meeting of the Governing Council of the European Central Bank on
4 April 2013, http://www.ecb.int/press/tvservices/webcast/html/webcast_130404.en.html.
Eichengreen, B. 1993: European
Monetary Unification. Journal of Economic
Literature, 31, 1321-57.
Feldstein, M. 1997: EMU and
international conflict. Foreign Affairs,
76, 60-73.
Giavazzi, F and Pagano, M. 1988: The
importance of tying one’s hands: EMS discipline and Central Bank credibility. European Economic Review, 32, 1055-1075.
Granville, B 2013: The current Eurozone – and impediment to
critical French reform. Centre for Globalisation Research Working Paper No.
42, March.
Herndon, T, Ash, M, and Pollin, R. 2013:
Does high public debt consistently stifle
economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff. Political Economy
Research Institute Working Paper No. 322, University of Massachusetts Amherst,
April.
IMF
2012: World Economic Outlook Database,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx, International Monetary Fund,
April.
IMF
2013a: World Economic Outlook Database,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx, International Monetary Fund,
April.
IMF
2013b: Greece. Ex post evaluation of
exceptional access under the 2010 stand-by arrangement, International
Monetary Fund, May.
Kaldor, N 1971: The dynamic effects of
the Common Market. The New Statesman,
12 March 1971.
Kawalec, S and Pytlarczyk, E. 2013:
Controlled dismantlement of the Eurozone: a strategy to save the European Union
and the Single European Market. German
Economic Review, 14, 31-49.
Kouparitsas, M.A. 1999: Is EMU a
viable common currency area? A VAR analysis of regional business cycles. Economic Perspectives, 4, 2-20.
Krugman,
P. 2012: Economics in the crisis. http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/05/economics-in-the-crisis/
Meade, J. 1957: The balance of
payments problems of a free trade area. Economic
Journal, 67, 379-96.
Mundell, R. 1961: A theory of
Optimum Currency Areas. American Economic
Review, 51, 657-665.
Panizza, U and Presbitero, A.F.
2012: Public debt and economic growth: is
there a causal effect? MoFiR working papers No. 65, April.
Perotti, R. 2011: The “austerity myth”: gain without pain? NBER
Working Paper No. 17571. November.
Reinhart, C and Rogoff, K. 2010:
Growth in a time of debt. American Economic Review 100: 573-78.
Sapir, J. 2012 : Le coût du
fédéralisme dans la zone Euro. Russeurope,
November, http://russeurope.hypotheses.org/453
Scitovski, T. 1958: Economic theory and western European
integration. Stanford University Press.
mercoledì 26 giugno 2013
Stop alle telefonate!
Per favore, non telefonate alla Fondazione Ugo La Malfa, perché domani non presenterò il mio libro. Abbiamo deciso di rinviare la presentazione a dopo l'estate per avere più pubblico.
Quando vado da qualche parte vi avverto via blog o Twitter. Siccome non vi avevo dato le coordinate (e su Twitter avevo detto che la cosa non si faceva più) speravo che ci fossimo capiti. Mi dispiace per l'inconveniente.
Quando vado da qualche parte vi avverto via blog o Twitter. Siccome non vi avevo dato le coordinate (e su Twitter avevo detto che la cosa non si faceva più) speravo che ci fossimo capiti. Mi dispiace per l'inconveniente.
martedì 25 giugno 2013
Postfazione a Europa Kaputt di A.M. Rinaldi
(vi anticipo la postfazione al testo di A.M. Rinaldi, uno studioso che avete imparato a conoscere qui e soprattutto qui...)
Accolgo con piacere l’invito dell’amico e collega Antonio
Rinaldi a tirare le fila del discorso. Compito non semplice, data la
complessità e la varietà dei temi sollevati dal suo testo, che, pur essendo
agile, affronta comunque il tema della crisi sotto una varietà di
sfaccettature, tutte ugualmente rilevanti: l’aspetto tecnico-economico, quello
storico, quello politico, quello sociologico.
Nel farlo porterò all’attenzione del
lettore gli aspetti che ho trovato più significativi nel mio percorso di
lettura, necessariamente individuale e soggettivo. Sarebbe molto difficile
immaginare due studiosi dal percorso tanto diverso quanto il mio e quello di
Antonio: lui proveniente, dopo una solida formazione, da un percorso di
responsabilità ai vertici di importanti aziende, dove ha svolto un’attività
operativa che l’ha avvicinato a quella classe dirigente italiana che dipinge in
modo piuttosto disincantato (e dobbiamo pensare che lo faccia a ragion veduta);
io, invece, proveniente da un percorso di ricerca accademica, totale outsider, distante dai palazzi del potere e
dalle dinamiche politiche italiane, interessato per anni allo studio delle
economie emergenti.
Eppure, due persone così diverse si sono trovate in prima
fila sui media italiani nel dibattito sulla crisi, perché accomunate da due
motivazioni profonde: il rispetto verso gli insegnamenti dei nostri maestri
(Paolo Savona nel suo caso, Francesco Carlucci nel mio), fra i pochi economisti
italiani ad aver osato esprimere tempestive posizioni di critica verso la
follia dell’euro; e la preoccupazione verso i nostri figli, ai quali avremmo
voluto, per usare le belle parole di Antonio, “riconsegnare il nostro paese
come lo abbiamo ricevuto”. Ma da tecnici, entrambi, con grande amarezza,
sappiamo già che questo non sarà possibile, quale che sia lo scenario che si venga
a materializzare: il piano A, B o D, per usare l’efficace categorizzazione
proposta da Antonio. I danni sono fatti, e trascendono ormai ampiamente la
dimensione economica.
È ormai lo stesso processo di integrazione culturale,
sociale e politica europea a conoscere una grave e forse irreversibile battuta
di arresto, le cui cause erano ampiamente note agli economisti: già Nicholas
Kaldor nel 1971, e poi Dominick Salvatore nel 1997, con tanti altri ricordati
nel testo, avevano denunciato il fatto che far precedere all’unione politica
l’unione monetaria avrebbe compromesso la prima, senza assicurare il successo
della seconda. I motivi sono ormai chiari a tutti e ben riassunti da Antonio
nel terzo capitolo di questo libro (L’Euro
non è una moneta): la mancanza di un prestatore di ultima istanza credibile,
cioè sorretto da un’unitaria volontà politica, per i governi dell’Eurozona,
trasforma anche attività normalmente prive di rischio, come i titoli del debito
pubblico, in attività soggette al rischio paese, alimentando lo spread, quel
fenomeno perverso in virtù del quale in caso di crisi il denaro costa di più
dove più sarebbe necessario per rilanciare l’economia.
È difficile trasmettere ai “laici” (cioè ai non economisti) l’assoluta
e totale prevedibilità di questi esiti perversi, che la letteratura economica
aveva non solo analizzato in termini teorici da tempo, ma anche descritto in
termini empirici, avendoli riscontrati nelle tante crisi finanziarie che hanno
flagellato i paesi emergenti negli ultimi trent’anni. Ma appunto, ricorda molto
opportunamente Rinaldi nello stesso capitolo, il nodo sta qui: l’adesione
all’euro ha di fatto comportato la conversione dei debiti pubblici dei paesi
membri in una valuta estera. A titolo di esempio, per il Portogallo, oggi, indebitarsi
in euro è come per l’Argentina negli anni ’90 indebitarsi in dollari: in
entrambi i casi, il governo non ha il controllo della valuta nella quale è
definito il suo debito, e per questo elementare fatto si trova in balìa dei
mercati.
È proprio questo fatto ovvio, banale, che disvela la natura
ideologica di una scelta politica e le ragioni economiche del suo fallimento.
Il progetto “eurista”, unanimemente rivendicato o biasimato come tappa di un
percorso “europeo”, in realtà è, dal punto di vista ideologico, l’espressione
del più retrivo liberismo di stampo statunitense, della più ottusa e
integralistica fiducia nell’onnipotenza dei mercati, quella che s’identifica
nella scuola di Chicago e nel Washington Consensus. L’euro è quindi il segno
tangibile della colonizzazione culturale del continente europeo da parte di precetti
di origine americana, fieramente discussi ormai nel mondo intero, a partire dai
pragmatici Stati Uniti, sempre disposti a rimettere in discussione un modello
qualora non funzioni. Disponibilità assente a Bruxelles e all’Eurotower.
In effetti, con l’euro si è accettato di mettere i paesi in
mano ai mercati sulla base del presupposto che i mercati, cioè il settore
privato, fossero efficienti e infallibili, e che di converso il settore
pubblico andasse comunque compresso perché inefficiente. L’euro era uno snodo
essenziale di questo progetto mercatista per due ovvi motivi.
Il primo lo abbiamo già detto, ed era di natura
essenzialmente politica: perché metteva gli Stati in mano ai mercati, con
l’idea che la perdita di sovranità democratica che ciò comportava sarebbe stata
compensata da guadagni di efficienza, visto che il mercato avrebbe effettuato
un indiretto ma penetrante scrutinio dell’efficienza dell’azione pubblica. In
Italia la pillola amara della perdita di sovranità è stata fatta ingoiare anche
diffondendo sistematicamente, in un popolo già morbosamente propenso
all’esterofilia e all’autodenigrazione, l’idea che gli italiani fossero comunque
incapaci di governarsi da soli, e che i nostri governi corrotti, clientelari,
incapaci, necessitassero delle briglie del vincolo esterno e delle regole
europee. Un’idea alla base del rifiuto da parte di Guido Carli della clausola
di opting-out, come ricorda Antonio nel
primo capitolo. Uno sguardo alla realtà europea ci rivela però che corruzione,
nepotismo, incapacità, sono un male più comune di quanto non si creda, il che,
pur non essendo motivo di vanto, rende ingiustificata la percezione negativa
che il popolo italiano ha di sé. Percezione, duole dirlo, alimentata
sistematicamente dai messaggi di biasimo che la classe politica e i mezzi d’informazione
non ci lesinano, dipingendoci sistematicamente come un popolo di lazzaroni
corrotti, e mostrando già solo per questo motivo quanto distorta sia la loro
concezione dell’interesse e della dignità nazionale. È un grande pregio del
libro di Antonio il rivendicare con orgoglio la dignità dell’essere italiani, il
difendere l’onorabilità di un popolo che ha saputo risollevarsi dopo tragedie
immani e che anche nelle attuali condizioni mostra di avere una stupefacente
riserva di energie e capacità di sacrificio.
Il secondo motivo è più sottile. Qual era il razionale
economico dell’euro? Certo non la promozione del commercio! Gli stessi studi della
commissione (ad esempio il celeberrimo One
market, one money) avevano chiarito con dovizia di dettagli che l’impatto
della moneta unica sul commercio sarebbe stato minimo: un dato confermato
retrospettivamente da Volker Nitsch, e
spiegabile con l’ovvio motivo che dopo decenni di cambio fluttuante i mercati
valutari fornivano (e tuttora forniscono) efficientissimi strumenti di
copertura contro le oscillazioni dei corsi a breve (quelle alle quali sono
esposte le transazioni commerciali). L’euro serviva quindi a favorire la
circolazione dei capitali, abolendo definitivamente il rischio di cambio su
contratti a medio/lungo termine (come sono quelli di credito/debito).
Intendiamoci: questa evoluzione (la facilitazione dei movimenti
di capitale) non sarebbe stata necessariamente negativa, ma lo diventava nel
momento in cui si ignoravano due dati di fatto: i grandi divari di sviluppo fra
i paesi dell’Eurozona, e l’assenza di controlli penetranti sui mercati.
Quando il Portogallo e la Grecia sono entrati nell’Eurozona,
il reddito medio dei loro cittadini equivaleva a quello tedesco all’inizio
degli anni ’80. I paesi periferici erano di vent’anni indietro rispetto
all’economia leader, ed era chiaro che per creare un’area effettivamente
integrata avrebbero dovuto correre di più. Un processo, quello di “recupero” (catch-up), fisiologico e previsto dalla
teoria economica, che l’afflusso di capitali avrebbe dovuto facilitare. Il
punto è che, così come quando si corre è normale sudare, quando si cresce di
più è normale che vi sia un po’ più di inflazione. Se non si permette al tasso
di cambio di compensare, cedendo fisiologicamente, questo fenomeno, il paese
ingaggiato in un processo di recupero perde competitività. Succede così che i capitali
che all’inizio affluiscono per finanziare lo sviluppo, alla fine affluiscano
per finanziare i consumi, visto che i prodotti locali, per via della maggiore
inflazione, sono diventati meno convenienti. Un fenomeno che era stato
evidenziato fin dal 1957 dal premio Nobel James Meade.
A questo punto la mobilità dei capitali diventa una droga.
Le economie periferiche continuano a recuperare terreno, e il tenore di vita
dei cittadini ad aumentare, solo nella misura in cui il centro li finanzi. Chi
eroga il prestito sa che sta finanziando consumi anziché sviluppo, ma in
assenza di controlli sta bene così a tutti, nella speranza che il cerino acceso
rimanga in mano a un altro.
Ma non può durare per sempre. Quando i crediti diventano
inesigibili, e scoppia la crisi finanziaria, il meccanismo dello spread mette
rapidamente in ginocchio le economie dei paesi più deboli, distruggendo la
redditività delle imprese e rendendole facile preda di investitori esteri
desiderosi di acquisire marchi e know-how di prestigio, ambiti sui mercati
emergenti, come quelli espressi da molte piccole e medie imprese italiane.
Paradossalmente, il disporre di una valuta troppo forte espone il paese alla
svendita dei propri gioielli di famiglia. Una svendita che Antonio denuncia con
forza, individuandone correttamente l’origine nel fallimento di mercati
finanziari privati che mai hanno rinunciato a elargire cospicui benefit ai
manager che prestavano largamente, senza discernimento. Le stesse istituzioni
private e gli stessi manager che ora vengono salvati dalle tasche del
contribuente, o convertendo i loro debiti privati in debito pubblico.
La svendita quindi altro non è che il portato di una
mobilità dei capitali incontrollata, o meglio controllata a senso unico,
perché, come ricorda Antonio in questo e nel suo precedente testo (Il fallimento dell’euro?), nell’Europa
dei figli e dei figliastri i tentativi del capitale italiano di acquisire
aziende estere sono stati sempre prontamente ostacolati da una rete di
protezione degli altrui interessi nazionali.
È ormai diffusa, e sarà presto patrimonio condiviso, la
percezione che questa svendita delle nostre aziende costituisca un grave
pericolo per la nostra sopravvivenza, semplicemente perché, se e quando l’economia
italiana dovesse ripartire, buona parte dei redditi prodotti in Italia
verrebbero rimpatriati all’estero (come profitti di aziende di proprietà
estera) e quindi goduti non dai cittadini italiani, ma da quelli dei paesi ai
quali il sistema euro, come Antonio efficacemente esprime, ha facilitato lo shopping delle nostre imprese. Ma
questo, in Italia, ancora non si sente dire, se non da studiosi indipendenti
(ad esempio, Dominick Salvatore alla lezione Felice Ippolito, 24 giugno 2013,
Biblioteca della Camera dei Deputati).
Questa analisi tecnicamente ineccepibile contrasta,
ovviamente, con l’elogio acritico degli afflussi di capitali esteri fatto dai
nostri governanti e dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria come
Confindustria. Soggetti che spesso sono contigui, quando non espressione
diretta, di quelle centrali finanziarie internazionali che dallo shopping hanno tutto da guadagnare (come
consulenti, come gestori), e che quindi sono in ovvio conflitto di interessi.
L’euro cadrà. Le affermazioni di Mario Draghi, secondo cui chi prende in considerazione questa ipotesi sottostima il capitale politico impegnato nel progetto europeo, sono futili. Un capitale politico ben più
rilevante era stato investito nell’Impero sovietico. Ma quando le leggi
dell’economia ne hanno decretato la fine, gli sforzi per prolungarne la
sopravvivenza si sono tradotti solo in un aggravio di inutili sofferenze per
popolazioni incolpevoli. Questo è lo stadio al quale siamo giunti. Ringraziamo Antonio
per questo testo che ci mette di fronte alla realtà, e ci consente di gestirla
delineando gli scenari possibili. Certo, la materia è problematica, è e sarà
oggetto di discussione. Ma nessuno potrà togliere ad Antonio, indipendentemente
dal merito specifico delle sue proposte, il merito ben più importante di aver
contribuito ad aprire un dibattito concreto, la cui assenza ha rappresentato
una grave lesione della democrazia nel nostro paese.
È atteggiamento adulto riconoscere gli errori, e l’euro è
stato un errore. Il perseverare, unica risposta che i nostri governanti e la
cosiddetta “Europa” ci forniscono, è atteggiamento puerile e suicida. Possa il
buon senso prevalere prima che la scure della storia si abbatta su una
costruzione resa antistorica, prima che antieconomica, dalla sua matrice
ideologica iniqua e sconfessata dai fatti, e prima che il nostro paese,
depauperato dall’azione poco lungimirante dei suoi governanti, perda le energie
necessarie per reagire con vitalità alle sfide che i mutati scenari gli
porranno.
lunedì 24 giugno 2013
Zucconi
(un post fulmineo perché si commenta da sé...)
Storie di ordinario terrorismo.
Prima ci ha provato coi mutui, poi con l'inflazzzzzione, ma gli è andata male. Notate la supponenza di chi pensa che mettere due dati in fila sia cosa banale (così vedono loro la nostra attività), l'arroganza di chi ti sbatte in faccia il proprio reddito, e altre piccole chicche sperse nei vari Storify. Del resto, la mela (marcia) non cade mai lontano dall'albero.
Grande tristezza, appena mitigata dalla soddisfazione intellettuale che ogni conferma, inevitabilmente, anche la più dolorosa, porta con sé.
Nil inultum remanebit. Son finiti i tempi che potevate dire la qualunque. E di questo ringrazio tutti voi lettori.
Addendum delle 15:14: su Twitter mi fanno notare che non è la prima volta!
(un caro saluto al mentecatto con l'ego in formazione che mi ha lasciato un commento di insulti dicendo che non avevo pubblicato il commento di IO e che con i suoi colleghi giornalisti ero stato mellifluo e accomodante! Carissimo, se mi dai il tuo nome e cognome sarò mellifluo e accomodante con te come con Zucconi. Come tu possa fare ad avere rispetto per te stesso, letto il post, è un grande mistero di filosofia morale, ma ne conosco di più appassionanti...)
Storie di ordinario terrorismo.
Prima ci ha provato coi mutui, poi con l'inflazzzzzione, ma gli è andata male. Notate la supponenza di chi pensa che mettere due dati in fila sia cosa banale (così vedono loro la nostra attività), l'arroganza di chi ti sbatte in faccia il proprio reddito, e altre piccole chicche sperse nei vari Storify. Del resto, la mela (marcia) non cade mai lontano dall'albero.
Grande tristezza, appena mitigata dalla soddisfazione intellettuale che ogni conferma, inevitabilmente, anche la più dolorosa, porta con sé.
Nil inultum remanebit. Son finiti i tempi che potevate dire la qualunque. E di questo ringrazio tutti voi lettori.
Addendum delle 15:14: su Twitter mi fanno notare che non è la prima volta!
(un caro saluto al mentecatto con l'ego in formazione che mi ha lasciato un commento di insulti dicendo che non avevo pubblicato il commento di IO e che con i suoi colleghi giornalisti ero stato mellifluo e accomodante! Carissimo, se mi dai il tuo nome e cognome sarò mellifluo e accomodante con te come con Zucconi. Come tu possa fare ad avere rispetto per te stesso, letto il post, è un grande mistero di filosofia morale, ma ne conosco di più appassionanti...)
sabato 22 giugno 2013
Argentina: Pasquino e la Presidenta
(andando a spasso con Uga in centro, alla fine dello scorso anno, vidi questo accorato appello affisso alla statua di Pasquino, che dopo tanti secoli, evidentemente, è ancora in funzione...)
(...e l’Argentina? Ma
cosa succede in Argentina? E perché non facciamo come in Argentina? Ma quanto è
brava l’Argentina! Ecc.
Ragazzi, dire “l’Argentina”
è come dire “la Germania”, ovvero non dire niente. Esistono molte Argentine e
molte Germanie, nello spazio e nel tempo. Vi ho già comunicato, tramite un corposo articolo
di Roberto Frenkel, qual è la sua analisi, che mi aveva riportato di persona
qui,
e che non ho motivi di non far mia, per la fiducia che mi ispira Roberto. Molto
semplicemente, la Presidenta, per la quale tanto ci si sdilinquisce da queste
parti, non sta facendo una buona politica macroeconomica. Capita. Non omnes
possumus omnia, e basta farsi un giretto su Twitter per capire cosa intendo.
Ovviamente, dal fatto
che dal 2007 l’Argentina non sia guidata in modo ottimale non si evince che nel
2001, sei anni prima, dovesse restare agganciata al dollaro. La crescita
folgorante avuta dal 2001 al 2007 lo dimostra a sufficienza, e solo gli
imbecilli non lo capiscono, perché non vogliono capirlo – ma la cosa, per
quanto phastidiosa, non ci preoccupa più di tanto: in particolare, dalle nostre
parti le cose finiranno come dico io, perché non lo dico io (ma Meade, Kaldor,
Thirlwall, Dornbusch, Feldstein,... vi risparmio tutta la lista), e poi FAREmo
i conti.
Il fatto è che l’ideologia
non paga.
Non paga né a sinistra
(ricordo la diffidenza degli economisti “de sinistra” italiani verso Frenkel,
basata sul “ma i miei colleghi argentini mi hanno detto che...”, laddove
verosimilmente i colleghi argentini erano aggreppiati al governo attuale, che
sta molto presumibilmente distruggendo il paese), né a destra. In particolare,
ai cretini del “se svalutassimo finiremmo come l’Argentina”, faccio notare che
nell’articolo che segue Martin Rapetti, coautore di Roberto in questo articolo
fondamentale, spiega molto bene che il
problema attuale dell’Argentina nasce dall’aver fatto affidamento sulla
politica del cambio forte per domare l’inflazione.
Cari amici “de destra”
e “de sinistra”, accomunati dal meschino astio ideologico e dal non capire un
cazzo di economia, ve lo dico in un altro modo: la Presidenta contro la quale
vi accanite, se siete “de destra”, sta facendo esattamente la politica
suggerita negli ultimi 40 anni dal
vostro solone Giavazzi (usare il cambio forte per domare l’inflazione), e la Presidenta
che venerate, se siete “de sinistra”, sta facendo esattamente la politica
suggerita dal loro (o vostro?) solone Giavazzi (usare il cambio forte per
domare l’inflazione).
Nell’uno e nell’altro
caso, se non foste quegli imbecilli che siete, capireste che c’è poco da
accanirsi (perché è controproducente per le vostre tesi), cioè c’è poco da
venerare (perché è controproducente per le vostre tesi).
Ma a noi piace
ricordarvi così, brancolanti nel buio della vostra cecità ideologica...
(Quanto ne ho pieni i
coglioni, però... Dovrei nasconderlo meglio?)
Per l’intelligibilità
del testo, ricordo che nel resto del mondo il tasso di cambio nominale è
quotato incerto per certo, cioè come prezzo in valuta locale di un’unità di
valuta estera (ad esempio, pesos per un dollaro), e che il cambio reale è dato
dal rapporto fra prezzi interni e prezzi esteri espresso in una comune valuta.
Se il cambio nominale è quotato incerto per certo, conviene esprimere il tasso
di cambio reale così:
dove Er è
il cambio reale (TCR), P sono i prezzi interni in valuta nazionale, PW
i prezzi esteri in valuta estera, e E il cambio nominale (prezzo locale della
valuta estera), per cui EPW sono i prezzi esteri in valuta locale, e
Er è il rapporto fra i prezzi interni ed esteri espresso nella
stessa valuta – quella locale. In tassi di variazione abbiamo:
per cui se, come dice
Martin, se nel biennio 2010 e 2011 i prezzi interni sono cresciuti del 54%,
mentre il cambio nominale si è svalutato solo del 12%, considerando che l’inflazione
mondiale media è stata del 4%, il TCR dell’Argentina dovrebbe essersi
apprezzato del:
54 – 12 – 4 = 38%
Calcolo assolutamente
approssimativo, perché i prezzi internazionali ovviamente vanno ponderati con
le quote di mercato dei partner commerciali, ma comunque indicativi.
Insomma, lo ripeto: non stanno
male perché hanno la pesetta, stanno male perché hanno il pesone. Che fa rima
con chi non lo capisce...).
Da Martin Rapetti ricevo e volentieri pubblico:
Torniamo a piangere per l'Argentina?
Non molto tempo fa, l’Argentina era considerata un caso di
successo economico. Nel 2001-02 il paese aveva sofferto una profonda crisi –
una triplice crisi che aveva coinvolto il settore finanziario, il debito
pubblico e la bilancia dei pagamenti – la peggiore crisi nella storia
dell’Argentina. Tuttavia, all’inizio del 2002, poco dopo la svalutazione del
peso, il default sul debito pubblico e il collasso del sistema finanziario,
l’economia iniziò una ripresa molto forte, che divenne poco dopo una forte
crescita economica. Alla fine del 2006 il Pil era cresciuto del 46% rispetto al
minimo raggiunto nel 2002 e del 17% rispetto al precedente picco di metà 1998;
la disoccupazione si era ridotta dal 22% all’8.7%, la povertà dal 58% al 28%, e
la povertà estrema dal 28% al 9%. Non è difficile capire come mai questa
esperienza sia diventata un esempio di successo nella soluzione delle crisi,
specialmente per paesi nella periferia dell’Eurozona come la Grecia.
L’esperienza Argentina dopo la crisi rappresentò anche un
esempio di successo in termini di scelte di politica macroeconomica. Nei primi
anni dopo la crisi, le autorità perseguirono politiche volte a mantenere un
tasso di cambio reale (TCR) stabile e competitivo, per promuovere l’espansione
dei settori aperti al commercio estero e attraverso questa lo sviluppo
economico. Il TCR competitivo fu un fattore chiave per la ripresa e la crescita
dell’Argentina. Molti economisti considerano la politica di mantenimento di un
TCR stabile e competitivo più favorevole allo sviluppo rispetto all’inflation targeting tradizionale
(politica di perseguimento di un obiettivo fisso di inflazione, come quella
della Bce, NdC).
Sfortunatamente, il successo economico dell’Argentina
cominciò a dissiparsi gradualmente. Come nella trama del classico libro di
Mario Vargas Llosa, Conversacion en la
catedral, è difficile stabilire in quale momento preciso questa esperienza “è
andata a puttane”. Un possibile punto di svolta è l’inizio del 2007, quando il
governo licenziò i funzionari dell’Ufficio Nazionale di Statistica (INDEC) e
cominciò a manipolare l’indice dei prezzi al consumo, con l’evidente scopo di
nascondere l’accelerazione dell’inflazione (da allora il tasso di inflazione
ufficiale è stato inferiore al 10% all’anno, mentre l’inflazione effettiva ha
oscillato attorno al 20-25% all’anno. Le manipolazioni si estesero in seguito
ad altre statistiche ufficiali, incluso il Pil). Ma indipendentemente dalla
data precisa, il problema è che il governo si è volto gradualmente verso un percorso
sempre più populista, basato su politiche monetarie, fiscali e dei redditi
eccessivamente espansive, che hanno alimentato l’inflazione. Invece di moderare
il ritmo della domanda aggregata, il governo ha sempre di più contato sul tasso
di cambio come principale ancora nominale per domare l’inflazione. Questa
strategia è stata particolarmente intensa nel 2010 e nel 2011. In questi due
anni, i prezzi interni sono cresciuti del 54%, mentre il cambio nominale (cioè
il prezzo di un dollaro US in valuta locale) solo del 12%. Di conseguenza, il TCR si è considerevolmente
apprezzato.
Tanto gli elevati tassi di inflazione quanto l’apprezzamento
del TCD (insieme con altre misure discrezionali) hanno compromesso l’ambiente
economico. In questo contesto Pil, investimenti, occupazione privata e crescita
dei salari reali hanno sofferto una decelerazione significativa. Alla fine del
2011, l’economia è rimasta bloccata nella trappola della stagflazione, dove
tuttora si trova (potete leggere altri dettagli qui).
Molti analisti sono convinti che l’Argentina abbia sprecato
un’opportunità unica per sostenere la rapida crescita raggiunta nei primi anni
dopo la crisi. È diffusa l’opinione che la svolta populista abbia generato
costi opportunità crescenti, che continueranno a essere pagati fino al 2015,
quando prenderà il potere un nuovo governo, che cambierà l’orientamento della
politica economica. Capisco questa valutazione, ma ritengo che i problemi
economici non risiedano tanto nelle opportunità perse, quanto negli squilibri
che si stanno accumulando, i quali verosimilmente alla fine porteranno ad un’altra
crisi economica.
Permettetemi di esporre le mie preoccupazioni cominciando
con lo spiegare la situazione nella quale l’Argentina si trova fin dai mesi
precedenti alle elezioni presidenziali dell’ottobre 2011. A quel tempo, la
percezione generale era che l’economia fosse poco competitiva (prodotti troppo
cari per gli acquirenti esteri), che il TCR si stesse apprezzando molto
rapidamente e che prima o poi il tasso di cambio nominale avrebbe dovuto essere
corretto al rialzo (cioè svalutato). Dato che la svalutazione non è molto popolare,
la gente si aspettava che avrebbe avuto luogo solo dopo le elezioni. Cercando
di anticipare questa mossa, il pubblico corse agli sportelli della banca
centrale per acquistare dollari USA, depauperando le riserve ufficiali.
Tuttavia, una volta rieletta Cristina Kirchner con il 54% dei voti, il governo
decise di non svalutare il peso. L’eccesso di domanda di dollari continuò e la
banca centrale continuò a perdere riserve.
Il governo avrebbe potuto tentare di correggere l’eccesso di
domanda di dollari con una svalutazione. Questa scelta avrebbe sicuramente
accelerato l’inflazione, ridotto i salari reali e contratto il livello dell’attività
economica e dell’occupazione. In altre parole, la correzione della
sopravvalutazione del TCR avrebbe implicato un aggiustamento del salari reali e
una contrazione dell’occupazione. Il governo considerò che questa opzione fosse
poco popolare, anche dopo aver vinto le elezioni, e decise invece di imporre
controlli sulle importazioni e sull’acquisto di valuta estera a scopo di
investimento finanziario.
Anche se queste motivazioni possono essere eque dal punto di
vista sociale, il punto cruciale rimane quello di stabilire se i controlli diretti
rappresentino una soluzione sostenibile. Le economie dell’America Latina hanno
sperimentato diversi controlli in passato. Una lezione appresa da queste
esperienze è che i controlli possono essere molto utili se li si implementa in circostanze
nelle quali i fondamentali macroeconomici sono sani. Per fondamentali sani,
intendo che i prezzi relativi (come il TCR) non siano disallineati (troppo alti
o troppo bassi rispetto a un ipotetico valore di equilibrio, NdC) e che i saldi fiscale e estero non
seguano traiettorie insostenibili. Tuttavia, queste esperienze hanno anche
mostrato che i controlli diretti non solo non sono in grado di correggere gli
squilibri macroeconomici, ma addirittura tendono ad aggravarli.
Considerate, a titolo di esempio, il caso dei controlli
diretti sul mercato valutario per evitare la svalutazione del cambio nominale
quando il TCR è sopravvalutato. I controlli impongono un taglio della
produzione a quelli che hanno necessità di dollari per la loro attività
economica e non hanno più accesso al mercato ufficiale. I controlli implicano
anche che gli esportatori sono costretti a convertire i loro ricavi a un tasso
di cambio che genera pochi profitti, o addirittura perdite (perché se il peso è
sopravvalutato, cambiando in pesos i ricavi incassati in dollari ottengono una
quantità di pesos inferiore, NdC).
Non è difficile vedere che in queste circostanze gli agenti sono incentivati ad
abbandonare il mercato. Perché mai effettuare una transazione nella quale perdo
soldi? I controlli quindi finiscono per indebolire o distruggere i mercati
esistenti, e stimolano la creazione di altri mercati: i mercati neri. Questi, a
loro volta, compromettono le transazioni e accorciano gli orizzonti temporali,
influenzando negativamente il livello di attività economica e occupazione. L’evidenza
storica mostra anche che il premio sui cambi al mercato nero tende a crescere
quanto più fitti sono i controlli e quanto più forti sono gli squilibri. L’allargamento
del premio (divario fra cambio ufficiale e cambio “al nero”, NdC) è particolarmente problematico,
perché incentiva a ridurre l’offerta e aumentare la domanda nel mercato
ufficiale. Gli esportatori sono incentivati a rinviare e sottofatturare i
propri ricavi, e gli importatori ad anticipare e sovrafatturare i propri
acquisti. Anche le imprese e le banche cercano di accedere al mercato ufficiale
per rimborsare anticipatamente i debiti esteri. La proliferazione di strategie
di questo tipo crea un circolo vizioso che amplifica l’eccesso di domanda sul
mercato ufficiale, la caduta delle riserve ufficiali, e la crescita del premio
sul mercato nero. A un certo punto, quando lo stock di riserve è prossimo alla
fine, la banca centrale non ha altra scelta se non svalutare. Nella maggior
parte delle esperienze in America Latina, questa svalutazione ha preso una
forma traumatica, con ampi overshooting
del tasso di cambio (quando il tasso di cambio si svaluta “troppo” rispetto all’ipotetico
valore di equilibrio si dice che overshoots,
cioè va oltre il bersaglio, NdC),
forti accelerazioni dell’inflazione, pesanti riduzioni dei salari reali, dell’attività
economica, dell’occupazione (chi conosce lo spagnolo può vedere il mio articolo
sul populismo macroeconomico nel
mio blog).
In Argentina stiamo osservando questo percorso tipico fin da
quanto le autorità cominciarono a introdurre controlli nei mercati valutari,
alla fine del 2011. Il premio sul mercato nero dei cambi è andato crescendo
sistematicamente, e adesso è attorno al 70% (cioè il tasso ufficiale è di 5.3
pesos per dollaro e quello al mercato nero è di 8.7-8.9 pesos per dollari, circa
il 70% in più). Le riserve ufficiali della banca centrale sono in caduta libera
e ora coprono 6.7 mesi di importazioni, la cifra più bassa negli ultimi 18
anni. Si sentono comunemente storie su sottofatturazioni di esportazioni o
sovrafatturazioni di importazioni, e di rimborso anticipato di debiti esteri.
Sfortunatamente, credo che una crisi da
svalutazione-inflazione sia estremamente probabile. Il governo non sembra né
consapevole della probabilità di una crisi di questo tipo, né disposto a
correggere gli squilibri che possono causarla. La mia paura è che col passare
del tempo la correzione (cioè la svalutazione reale) finirà per essere molto
traumatica (e questo vale anche per noi, NdC).
Ecco perché lo penso: a causa dei controlli, molte imprese e famiglie hanno
investito i propri risparmi in attività finanziarie interne (denominate in
pesos), invece che in dollari USA, che sono lo strumento di investimento dei
risparmi più corrente in Argentina (la dollarizzazione dei portafogli di
investimento è il risultato di una lunga storia di inflazione elevata e persistente.
Per questo motivo, M3 (la moneta in senso largo, che include le varie tipologie
di depositi bancari e di attività finanziarie a breve termine) è cresciuta di
circa il 60% dall’ottobre 2011 (per forza: tutti chiedono attività denominate
in pesos, NdC) e il rapporto fra M3 e
le riserve ufficiali è saltato da 1.9 a 3 (cioè M3 valutata al cambio ufficiale
ora è pari al triplo dello stock di riserve ufficiali della banca centrale). La
mia paura è che questa domanda “indesiderata” di pesos potrebbe venire a
mancare bruscamente se il settore privato si aspetta che il tasso di cambio stia per fare un salto (verso l’alto: svalutazione, NdC). Per dirla schiettamente: non si sfugge a una svalutazione
reale; potrebbe verificarsi tramite una svalutazione, o tramite una crisi
valutaria. In entrambi i casi, il comportamento più probabile del settore
privato sarebbe quello di convertire in dollari i propri investimenti in M3.
Dato lo stock relativamente basso di riserve ufficiali, questa riallocazione
del portafoglio aggiungerebbe una fortissima pressione al rialzo (svalutazione
del peso, rivalutazione del dollaro, Ndc)
sul tasso di cambio, che rischierebbe di spingere verso l’altro i prezzi
interni. Il TCR andrebbe oltre il valore di equilibrio, influenzando
negativamente i salari reali e l’occupazione. Questo è il tipo di crisi
inflazionistica che temo. Spero di sbagliarmi.
(sapessi io...)
Martin Rapetti è ricercatore associato al Centro per lo
Studio dello Stato e della Società (CEDES) e ricercatore all’Università di
Buenos Aires. Si interessa di macroeconomia, finanza, sviluppo economico ed
economia dall’America Latina.
(inutile, vi assicuro,
cercare di far capire ai coglioni che “Bagnai è un voltagabbana” che anche
queste cose le dico da mesi. Ricordatevi: meglio risparmiare i clic del mouse, nonostante non siano esattamente dei soldi, come pensa qualche squinternato dilettante allo sbaraglio...).
Addendum delle 23:08: corretti i refusi grazie a uno di voi (che se vuole essere nominato, si nominerà). Ma ce ne saranno ancora molti...
Iscriviti a:
Commenti (Atom)